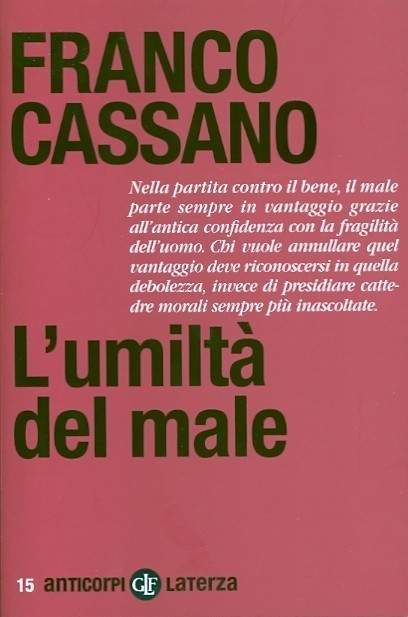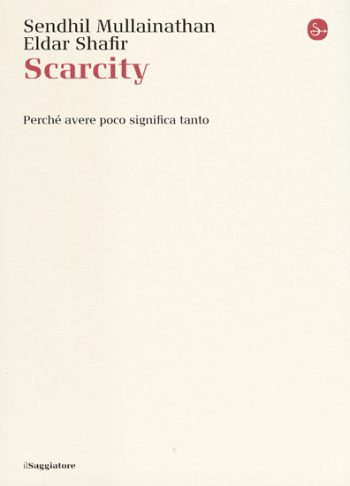DOPO LA PANDEMIA. LAVORO, CITTÁ, DEMOCRAZIA
|
|
Cosa abbiamo imparato[1]
Things will get worse before they get better (Dr. Anthony Fauci) Il nostro saggio cerca di mettere a fuoco tre ambiti su cui la pandemia ha già manifestato forti conseguenze e continuerà ad averne in futuro: il lavoro, le città, la democrazia. Che cosa abbiamo imparato da questa storia, peraltro in corso? Abbiamo imparato che esiste una vita parallela alla nostra, quella del virus - in realtà non una vita, in quanto non metabolizza alla luce del sole – che sta mettendo a rischio un’altra vita, la nostra. La storia è piena di episodi in cui virus piccolissimi ci hanno aggredito e sterminato. Li avevamo rubricati come fatti del passato. Ma ora si sono riproposti altri inaspettati episodi che abbiamo cercato di affrontare con l’ottimismo che la scienza ci consente. Abbiamo compreso che il Covid non era una semplice influenza come volevamo sperare. Il bisogno di solidarietà si è infranto contro la crescita delle diseguaglianze, le differenze sociali e culturali e la frammentazione degli interessi. Abbiamo incontrato una politica talvolta salottiera, spesso impotente, ospite di gala dei numerosi talk show. Il governo ha imposto il lockdown che nei tempi passati si sarebbe chiamato coprifuoco. Da veri italiani che danno il meglio quando sono messi peggio, ci siamo adattati. Il telelavoro, termine che aveva sostituito il vecchio lavoro a domicilio, si è trasformato in smart working, in cui si coniugano capacità di adattamento, intelligenza e l’antica tradizione artigianale delle botteghe rinascimentali. Siamo diventati imprenditori di noi stessi. Lo smart working ci spingerà a desiderare abitazioni che comprendano nuovi spazi. Intanto abbiamo cercato di attrezzare gli spazi domestici affinché potessero contenere tutto: lavoro, ricreazione, gioco, conforto. La casa si è trasformata in trincea, come quelle sui nostri monti al tempo della grande guerra, quelle trincee contenevano tutto, compresa la fiducia necessaria per sopravvivere e per vivere. Così abbiamo pensato a come avrebbero potuto essere le nostre città, lavorando a casa. Abbiamo anticipato i progetti dei nostri grandi architetti, abbiamo riletto il maestro Calvino e le sue città invisibili. Venezia è diventata il simbolo della nuova città, un arcipelago dislocato su tante isole, una rete di piccoli territori interconnessi separati e uniti al tempo stesso, separati dal mare che unisce senza sommare, separa senza allontanare. Le costrizioni del confinamento hanno portato ognuno di noi a interrogarsi su questioni inedite. Abbiamo vissuto in uno spazio chiuso e in una strisciante condizione di paura. Ci siamo illusi talvolta che la pandemia fosse alle spalle, e poco dopo abbiamo sperimentato l’inconsistenza felle nostre speranze. Il Coronavirus ha fatto irrompere la morte come possibilità per ognuno e un nuovo senso di impotenza rispetto al pericolo che avevamo difronte. Il confinamento ci ha reclusi all’interno delle nostre case, con la ricorrente illusione che fossimo ogni volta difronte all’ultimo sacrificio. Il confinamento è stato una lente di ingrandimento delle diseguaglianze sociali: le abitazioni più anguste e affollate hanno reso il confinamento invivibile, ma le persone sole hanno vissuto una solitudine altrettanto dura. Abbiamo visto diseguaglianze che avevamo rimosso, quelle della donna, in primo luogo, più impegnate in lavori di cura, nel fronteggiare nuove esigenze, quelle dei figli, dei nipoti, dei genitori anziani. La pandemia ha colpito il mondo in modi diseguali e ha diffuso uno stato di ansia. Ci siamo interrogati, talvolta senza avere neppure consapevolezza, sulla nostra civiltà. Ci siamo ritrovati senza risposte. Una crisi dell’intelligenza, così Morin ha definito il buco nero che si è manifestato davanti a noi di fronte alla pandemia. L’incertezza dei rimedi ci ha messo di fronte all’inadeguatezza delle nostre conoscenze. Abbiamo capito che avevamo rimosso il rischio non solo dalla vota quotidiana, ma anche dalle categorie mentali con cui pensavamo la nostra esistenza. In questi mesi esigenze di protezioni sanitarie si sono scontrate con la necessità di favorire la ripresa economica, la necessità di salvaguardare la nostra libertà individuale con misure di tracciamento individuale. La crisi sanitaria è ancora in corso e insieme a questa vediamo l’esplosione del numero dei disoccupati e dei lavoratori precari. Crisi sociale, crisi economica e crisi politica sono con evidenza davanti a noi. Una crisi esistenziale quella che stiamo vivendo, che ci impone un nuovo rapporto con il tempo, che conosce una obbligata decelerazione, consentendoci di sperimentare talvolta il gusto della lentezza e della riflessione. Nello spazio chiuso sono emerse talvolta nuove abitudini sociali, gli scambi di aiuto con i vicini hanno dato luogo a nuove amicizie. Abbiamo sperimentato modi dimenticati per trascorrere il tempo: leggere, vedere film, ascoltare musica. Qualcosa di queste abitudini resterà per favorire modi di vivere più attenti al valore della reciprocità. Sul fronte della politica, per citare ancora Morin ‘è emerso chiaramente che la globalizzazione, poiché essenzialmente tecno-economica, ha creato una generale interdipendenza priva di ogni solidarietà’. Il Covid è stata l’occasione per ripensare il nostro modo di stare insieme, di essere uniti e separati al tempo stesso. Ci siamo chiesti come il nostro stare insieme potesse prescindere dall’idea del mondo di ciascuno. Come nella metafora dei porcospini, proposta da Arthur Schopenhauer, abbiamo cercato la distanza ‘giusta’ per scaldarci senza pungerci. Abbiamo capito la necessità delle decisioni in tempi rapidi, abbiamo scoperto l’importanza delle competenze, abbiamo ascoltati i virologi con l’attenzione delle antiche tribù verso gli sciamani. Abbiamo capito ancora una volta che rappresentare il popolo non basta; bisogna mettersi al servizio della comunità, perché nei momenti di grande difficoltà, è necessario il contributo di tutti secondo le capacità di ognuno. Abbiamo scoperto la resilienza, quell’atteggiamento soggettivo che scaturisce da prove difficili, che si percepisce quando si supera un’avversità e si può guardare indietro e ragionare su quanto si è stati forti in quella circostanza e sulla saggezza che abbiamo elaborato. Ora siamo in condizioni di guardarci indietro. Quasi non riusciamo a spiegare come siamo riusciti a fronteggiare questo tempo che peraltro non è ancora alle spalle. [1] Tratto da: Maura Franchi, Augusto Schianchi ‘Dopo la pandemia. Lavoro, città, democrazia’ Diabasis 2021 |
THE GAME
Alessandro Baricco, 2018, Einaudi
The Game di Alessandro Baricco è stata una delle mie letture dell’ultima estate.
La quiete pomeridiana all’ombra del mio terrazzo, il buon caffè e la temperatura gradevole, unite alla minore pressione degli impegni di lavoro, hanno rappresentato ingredienti di certo importanti per la qualità dell’esperienza, che è stata per me particolarmente ricca e stimolante.
Baricco è un autore al quale per molti motivi (anche di complicità con i miei figli nella fase della loro prima adolescenza, ormai molti anni fa) sono stato legato per così dire ‘sentimentalmente’, prima di ritrovarlo invece, in alcune occasioni, piuttosto barocco (credo che giocare sulla prossimità dei termini baricco-barocco non costituisca in effetti una grande originalità, eppure l’ho fatto), per cui ho esitato a lungo prima di affrontare il suo testo.
E devo riconoscere che le prime 50 pagine (così come mi era capitato con ‘Il nome della rosa’ di Umberto Eco) hanno messo a dura prova il mio desiderio di farmi accompagnare in un territorio che peraltro avevo percorso già altre volte, ma da punti di vista diversi e con diverse prospettive, diversi linguaggi, e attraverso il contributo di diversi autori.
Ma come spesso succede, l’investimento in attenzione, continuità e perseveranza ‘porta in dono’ un guadagno intellettuale appagante.
Ho trovato in questo testo uno sguardo originale, eterodosso, un poco ‘de-lirante’ nel senso etimologico, e cioè nel senso di ‘fuori dai solchi già tracciati’.
Tra le tante riflessioni, alcune mi hanno particolarmente sollecitato, anche quando il termine con la quale sono state sintetizzate nell'indice avrebbe potuto in realtà farmi pensare a qualche forma di deja-vu: ad esempio quelle sul tramonto delle mediazioni, sull'oltremondo, sul movimento, sulla superficialità, sulla post-esperienza di sé; e in particolare quella sulla verità, la post-verità e la verità-veloce (sulla quale riporto qui di seguito alcuni brani), che ancora più di altre ha rappresentato per me un elemento di spiazzamento e di ristrutturazione cognitiva.
E poi, l'ultimo capitolo del testo, quel 'Contemporary humanities. Quel che resta da fare' che costituisce un'autentica miniera di suggestioni.
E che mi ha sollecitato ad affrontare un nuovo volume (The Game Unplugged), sul quale magari svolgerò qualche considerazione in uno dei prossimi interventi.
La quiete pomeridiana all’ombra del mio terrazzo, il buon caffè e la temperatura gradevole, unite alla minore pressione degli impegni di lavoro, hanno rappresentato ingredienti di certo importanti per la qualità dell’esperienza, che è stata per me particolarmente ricca e stimolante.
Baricco è un autore al quale per molti motivi (anche di complicità con i miei figli nella fase della loro prima adolescenza, ormai molti anni fa) sono stato legato per così dire ‘sentimentalmente’, prima di ritrovarlo invece, in alcune occasioni, piuttosto barocco (credo che giocare sulla prossimità dei termini baricco-barocco non costituisca in effetti una grande originalità, eppure l’ho fatto), per cui ho esitato a lungo prima di affrontare il suo testo.
E devo riconoscere che le prime 50 pagine (così come mi era capitato con ‘Il nome della rosa’ di Umberto Eco) hanno messo a dura prova il mio desiderio di farmi accompagnare in un territorio che peraltro avevo percorso già altre volte, ma da punti di vista diversi e con diverse prospettive, diversi linguaggi, e attraverso il contributo di diversi autori.
Ma come spesso succede, l’investimento in attenzione, continuità e perseveranza ‘porta in dono’ un guadagno intellettuale appagante.
Ho trovato in questo testo uno sguardo originale, eterodosso, un poco ‘de-lirante’ nel senso etimologico, e cioè nel senso di ‘fuori dai solchi già tracciati’.
Tra le tante riflessioni, alcune mi hanno particolarmente sollecitato, anche quando il termine con la quale sono state sintetizzate nell'indice avrebbe potuto in realtà farmi pensare a qualche forma di deja-vu: ad esempio quelle sul tramonto delle mediazioni, sull'oltremondo, sul movimento, sulla superficialità, sulla post-esperienza di sé; e in particolare quella sulla verità, la post-verità e la verità-veloce (sulla quale riporto qui di seguito alcuni brani), che ancora più di altre ha rappresentato per me un elemento di spiazzamento e di ristrutturazione cognitiva.
E poi, l'ultimo capitolo del testo, quel 'Contemporary humanities. Quel che resta da fare' che costituisce un'autentica miniera di suggestioni.
E che mi ha sollecitato ad affrontare un nuovo volume (The Game Unplugged), sul quale magari svolgerò qualche considerazione in uno dei prossimi interventi.
|
Il brano che segue è tratto dalla sezione D, capitolo 1 "Stelle Comete"
Nel campo aperto del Game, molte cose sembrano diventate imprendibili, e una è la verità. Oddio, la verità: diciamo un profilo certo delle cose, una versione verificabile dei fatti, una definizione attendibile di quel che accade. Sarebbe già qualcosa poter contare su questa forma, minore, di verità. Ma non è così. Nel Game qualcosa sembra rendere la verità dei fatti ancora più sfuggente di quanto sia stata in passato. D'altronde se scegli un tavolo da gioco in cui la prima regola è il movimento, non sarà mai poi così facile poter disporre dei fatti in quello stato di fermezza che sembra necessario a fissarli in una definizione certa. Se accetti di aprire il gioco a un gran numero di player, il ritratto quotidiano del mondo sarà la composizione di così tanti angoli di visuale che la nettezza dell'immagine, alla fine, ne risentirà pesantemente. Se vai per il mondo con l'andatura lampo del post-esperienza, ci metterai poco a capire che, per te, la verità è una sequenza di fotogrammi in cui qualsiasi fotogramma, preso di per sé, non è né vero né falso. Provo a dirlo in termini più semplici possibili: il Game è troppo instabile, dinamico è aperto per essere un habitat gradito a un animale sedentario, lento e solenne come la verità. … Da un po’ di tempo, tanto per avere l'illusione di gestire la faccenda, usiamo una categoria che ci dà grande soddisfazione: la post-verità. Traduco. Ci siamo convinti che il Game abbia originato un mondo in cui la verità dei fatti non sia poi così decisiva per formarsi delle opinioni o prendere delle decisioni: apparentemente, siamo andati oltre, abbiamo sorpassato i fatti, ci muoviamo sulla base di improvvisate convinzioni fondate sul nulla, se non su notizie palesemente false. La forza di penetrazione di simili convinzioni è data dal fatto che si presentano molto semplici ed elementari, compatte come quelle che Cartesio chiamava “idee chiare e distinte”. Molte volte la loro forza è data anche da una confezione impeccabile e astutissima. In particolare - si dice - fioriscono là dove si è radicato il risentimento per l’élite, per gli esperti, per quelli del club in cui in tempi passati si costruiva la verità. Non dar peso alla verità dei fatti finisce per essere un modo di metterli fuori gioco: probabilmente è la coda di una ribellione partita molto tempo prima. Ora la domanda da farsi sarebbe: è una teoria valida? Questa della post-verità, dico, è una teoria utile a capire le cose? Dopo aver studiato per pagine e pagine il Game, una cosa possiamo dirla con tranquillità: è una teoria troppo elementare per spiegare quello che sta succedendo. Il Game non è così semplice né infantile. Nel Game non ci sono quelli intelligenti che hanno rispetto dei fatti e i cattivi che sono capaci solo di ragionamenti gastrointestinali. L'idea che una parte dell’umanità sia decollata grazie la rivoluzione digitale verso un irrazionalismo ignorante e oscurantista, facilmente manovrabile, è inadatta a spiegare che cosa è successo alla verità, ai fatti, e alla nostra elaborazione di essi: provate a fare del sushi con un’accetta e avrete maggiore successo. … LA GENIALE MACCHINETTA DELLA VERITÁ-VELOCE La verità-veloce è una verità che per salire alla superficie del mondo - cioè per diventare comprensibile ai più e per essere rilevata dall'attenzione della gente - si ridisegna in modo aerodinamico perdendo per strada esattezza e precisione e guadagnando però in sintesi e velocità. Diciamo che continua a perdere in esattezza e precisione fino a quando non giudica di aver ottenuto la sintesi e la velocità sufficienti per raggiungere la superficie del mondo. Quando le ha ottenute, si ferma: non butterebbe mai via un solo grammo di esattezza più del necessario. In un certo senso va immaginata come un animale che gareggia con molti altri per la sopravvivenza. Ogni mattino si svegliano molte verità e tutte hanno il solo obiettivo di sopravvivere, cioè di essere conosciute, di raggiungere la superficie del mondo: a sopravvivere non sarà la verità più esatta e precisa ma quella che viaggia più veloce, che raggiunge per prima la superficie del mondo. Prendiamo l'esempio del vinile. Il fatturato del vinile nel 2016 ha superato quello della musica digitale. Assumete questa frase come il prodotto finale di un viaggio molto lungo e cercate di risalire al punto dove quel viaggio si è messo in moto. Se lo fate, troverete una cosa vera: contro ogni logica si sono vendute negli ultimi anni, sul pianeta Terra, decine di milioni di dischi in vinile. È una verità curiosa e ha tutta l'aria di insegnare qualcosa di utile. Si sveglia al mattino inizia a correre. Per un certo tempo non trova la scorciatoia per salire in superficie, e quindi nessuno la percepisce (è 10 anni che il vinile aumenta regolarmente le vendite, ma non se n'era mai parlato). Poi d'improvviso trova un varco: una piccola settimana in cui in Inghilterra è successo che il vinile facesse più fatturato dei download. L' animaletto ci si butta. L'accelerazione è data dal fatto che qui la verità da cui si è partiti trova un assetto aerodinamico fantastico, si mette per così dire in posizione a uovo: assume la forma di un duello, vinile contro download, analogico contro digitale, vecchio mondo contro nuovo mondo. I duelli attirano sempre l'attenzione, semplificano le cose e sono veloci da capire. Ciò che può essere riassunto in duello avrà vita facile nella quotidiana lotta per la vita. “Achille contro Ettore” non perde da millenni. Perfetto. Ma non basta. Quante probabilità ha di sopravvivere la notizia che per una settimana, nel Regno Unito, il vinile ha stecchito in duello i download gratuiti delle piattaforme di musica digitale? Scarse. Per diventare memorabile, un duello non deve solo avere i protagonisti giusti (due eroi), ma anche svolgersi nel luogo giusto (main street) e celebrarsi all'ora in cui tutti li possono vedere. Quindi è purtroppo necessario ancora un piccolo lavoro di restyling, bisogna rassegnarsi a buttare a mare qualcosa, a perdere una piccola quota di esattezza: tocca far cadere quel “per una settimana” e se ancora non basta quel “nel Regno Unito”. Fatelo, non discutete. Temo che ci sia ancora da sorvolare un attimo sulla genericità del termine “musica digitale”. Sorvolate. Bene. Ottimo lavoro. Il fatturato del vinile, nel 2016, ha superato quello della musica digitale. Voilà. Notizia in pagina, missione compiuta. Chiedersi a questo punto se la notizia sia vera o falsa non è magari scemo ma certo non è urgente, non è così decisivo. Perché quella notizia ha comunque in pancia una verità e proprio grazie alla sua imprecisione ha portato sulla superficie del mondo qualcosa di molto importante: la registrazione di uno strano contro-movimento che riga il nostro rettilineo andare verso il futuro. Come un apparente imprevedibile rigurgito di un passato. Non è esattamente un fenomeno da nulla, e l’averlo registrato arricchisce sicuramente la nostra lettura del mondo. Che a generarlo sia stata una notizia imprecisa è poi così importante? Non ho una risposta sicura, ma, mentre la cerco, inizio a rendermi conto che quella notizia (inesatta) non solo ha disseppellito una verità degna di nota, ma ne ha liberato altre, più piccole, che non avrebbero mai avuto accesso alla mia attenzione e che solo adesso, nella luce della verità- veloce, assumono visibilità e significato: scopro che non solo aumentano da anni regolarmente le vendite del vinile, ma anche delle penne stilografiche, delle macchine da scrivere e, ben più importante, del libro cartaceo (fra un po’, mi sa, torneranno in auge la carta copiativa e le pantofole). In pancia, quella notizia ha quelle verità, e finalmente le rende visibili, se le trascina dietro fino alla superficie del mondo portandole sotto i riflettori della nostra attenzione. Mi accorgo allora che si sta formando una sorta di agglomerato di fatti, una costellazione, che riconduce tutti quei fenomeni a una figura più generale, ora facilmente riconoscibile , che chiamerei “vendita di tecnologie obsolete ma vagamente poetiche”: la sua insorgenza spinge ancor più gente a entrare in un’orbita di curiosità per quel segmento particolare del mercato (che con ogni probabilità aveva in precedenza dimenticato) e ad appassionarsi al pensiero di un acquisto, il che immancabilmente genererà un rinnovato interesse delle aziende produttrici le quali aumenteranno la produzione, moltiplicando l'offerta e stimolando la richiesta. Soldi, lavoro, fatti. Ciò che non era veramente vero, ha qualche possibilità di diventarlo in futuro. Impressionante come un’inesattezza possa generare tanto senso e tante realtà: ma lo fa. Se foste tentati di scuotere il capo e pensare dove siamo finiti, o ancor peggio di attribuire alla nostra nuova civiltà questa perversione di generare realtà a partire da verità imprecise, devo richiamarvi ai fatti e ricordarvi che la verità-veloce non è un’invenzione dell’era digitale, e nemmeno della modernità. È un marchingegno molto antico, che già moltissimo tempo fa era costruito e manovrato con grande abilità. Facciamo un esempio: Achille. Quello dell'Iliade. Era tramandato come un semidio: suo padre era un uomo e sua madre una dea. Verità-veloce. È difficile dire adesso se i greci dell'VIII secolo A.C. credessero veramente che Achille fosse nato da un amplesso tra un uomo e una dea, ma è ragionevole azzardare che non si ponessero più di tanto il problema perché nell’espressione, imprecisa, semidio, tramandavano qualcosa che per loro era assolutamente vero, e cioè che in Achille era registrabile una forza, una violenza, una follia e un' invulnerabilità che loro non sapevano spiegare, che non ritrovavano nel destino degli umani, e in cui intravedevano l'inquietante mistero di una disumanità possibile e invincibile. Si dirà che quelle erano leggende, miti, poesia. Ma non è così corretto: al tempo, quella era la forma dell’informazione, i media erano i poemi Omerici, l’Iliade era un’enciclopedia che sintetizzava tutto il sapere dei Greci. Era il loro modo di tramandare la verità. In ogni caso, la formula del semidio la ritroverete senza fatica quando ai miti e alle leggende si sostituì definitivamente la storia: da Alessandro Magno in poi, qualsiasi aspirante padrone del mondo ha dovuto presentarsi come un discendente, se non figlio, di un Dio. Giulio Cesare non era il personaggio di una fiction né la visione di un poeta: tuttavia discendeva da Venere, e ci teneva a ricordarlo. Nessuno l'avrebbe messo in discussione. Erano tutti scemi? No, usavano la verità-veloce per leggere il mondo. Così padroneggiamo la tecnica della verità-veloce da millenni e se mi chiedete perché allora essa appare invece così congeniale alla nostra epoca, sembrando quasi una sua creatura, fate una domanda affascinante la cui risposta, se avete letto questo libro, già conoscete: perché il Game e in effetti è l'habitat ideale per una simile idea di verità e quindi in esso quell’idea è decollata dopo millenni di sonnolenza. Esisteva da sempre, ma era costretta a manovrare in sistemi ad alta densità, dove le notizie circolavano con lentezza, maneggiate da pochi addetti ai lavori. Correva, ma al ralenti. nel Game ha trovato improvvisamente il proprio campo da gara perfetto. Bassa densità, infiniti player, attrito ridotto al minimo, tempi di reazione velocissimi, sterminato numero di percorsi. Una pacchia. E infatti la verità-veloce si è presa il centro del campo ed è, essa stessa, lievitata, nella sua forza, nelle sue potenzialità, nella sua statura. Se per tutto il 900 era sembrata per lo più una caricatura pericolosa della verità vera - quella fondata sulla permanenza, sulla fissità, sulla definizione - nel Game si è presa la rivincita dimostrando che nel suo andare un po’ pazzo che viene dal nulla e non finisce mai, finiva per pescare a strascico un sacco di mondo. Aveva un design adatto a catturare e produrre ampie sezioni di mondo. Questo va capito bene, questa cosa della forza della verità-veloce: datemi qualche minuto di concentrazione e tornate con me a quella storia del vinile. Eravamo arrivati al punto in cui una sorta di verità inesatta (il vinile vende più della musica digitale) ne esprimeva una esatta (c'è un ritorno curioso, massiccio e crescente a tecnologie obsolete ma portatrici di qualche poesia). Bene: non prendetelo per un punto di arrivo, perché non lo è. Ha già fatto un sacco di strada quella verità-veloce, ma non è mica finita lì. Il meglio deve ancora arrivare e arriva quando quella verità-veloce imbocca la discesa delle interpretazioni. È un momento bellissimo, è pura ebrezza della velocità. Quel che accade è che, data quella verità-veloce, almeno due sono i modi di leggerla:
Vi chinerete, allora, con rinnovata curiosità e cresciuto rispetto, su quella macchinetta sofisticata: e di certo non mancherete di notare come vi affascini, in un simile modello di verità, il fatto che inizi con un’imprecisione, con una mezza verità. Vi colpisce la sua abilità a convertire quella perdita iniziale in un vantaggio strategico: il sacrificio della precisione genera leggerezza, velocità, agilità, efficacia, volendo perfino bellezza. Movimento, diffusione, esperienza. Rischioso, penserete, spaventandovi. Certo. Ma lo penserete mentre simultaneamente vi starete rendendo conto che voi quello schema lo conoscete, è quello che governa tutti i tool digitali, è la storia dell’MP3, meno suoni ma più trasportabile, è la storia del passaggio al digitale, un filo di imprecisione in più in cambio di un’immensa agilità. È la storia della superficialità al posto della profondità. È la forma del Game. Così, passo dopo passo, arriverete ad ammettere che sotto gli occhi avete una macchinetta molto sofisticata, estremamente coerente con il vostro modo di stare al mondo, e fantasticamente adatta all’ecosistema del Game. Pericolosa, certo. In gran parte ancora da capire. Ma degna di essere presa sul serio. In quel momento, vi giuro, l'idea che tutto sia andato in vacca, che i fatti non contino più nulla e che viviamo ormai nell’epoca del post-verità vi sembrerà un tantino rozza. Per quel che ne capisco io è una tipica verità-veloce: parte da un'imprecisione, è una semplificazione brutale, e poi si muove magnificamente nel Game, dragando inerzie e correnti sotterranee, dando un nome articolato a una convinzione gastrointestinale e traducendola in pensiero corretto. Un lavoro ben fatto. Chapeau. Se non ti convince hai solo da provare a costruire verità-veloci ancora più veloci. È giusto quel che sto facendo, adesso che ci penso. |
ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLA SOCIETÁ DELL’INCERTEZZA
Zygmunt Bauman (‘sociologo, filosofo e accademico’, come lo definisce Wikipedia) è stato uno degli autori più prolifici e allo stesso tempo più noti ad intervenire sui temi della modernità in questi ultimi decenni (‘liquida’ è l’aggettivazione con la quale ha caratterizzato il dibattito). A lui devo tra le altre cose una metafora che utilizzo spesso nei miei interventi: quella della distinzione tra missile balistico e missile ‘intelligente’, metafora che apre a suggestioni molto feconde, sia che si parli di competenze, di formazione, di orientamento, che di strategia d’impresa. Riflettendo su istruzione e formazione (oggi che esse sembrano tornare al centro del dibattito sullo sviluppo economico-sociale), mi è tornato alla mente un suo contributo di diversi anni or sono (venti, per la precisione), che considero ancora di grande attualità, e di un interesse straordinario. Ne riporto di seguito alcuni passaggi particolarmente significativi e ‘risonanti’.
|
Il brano che segue è tratto da L’istruzione nell’età postmoderna, in Zygmunt Bauman La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza Il Mulino, 2002
Riassumendo decine di anni dedicati allo studio degli stili di vita praticati da numerose società differenti, vicine e lontane, Margaret Mead giunse alla seguente conclusione: ‘la struttura sociale di una società e il modo in cui è strutturato l’apprendimento - il modo in cui passa dalla madre alla figlia, dal padre al figlio, dal fratello della madre al figlio della sorella, dallo sciamano al novizio, dagli specialisti di mitologia agli aspiranti specialisti - determina, bel al di là del contenuto concreto dell’apprendimento, sia come gli individui impareranno a pensare che come vengono condivisi e usati i depositi culturali, la somma totale dei singoli pezzi di abilità e conoscenza’. In questa affermazione Mead non si richiama al concetto di deutero-apprendimento o di apprendere ad apprendere, coniato un quarto di secolo prima da Gregory Bateson, suo compagno nella vita; tuttavia rende chiaramente omaggio alla sua concezione quando assegna il ruolo primario e decisivo nel processo di insegnamento e di apprendimento al contesto sociale e al modo in cui il messaggio è veicolato, piuttosto che al contenuto dell’istruzione. Il contenuto-oggetto di quello che Bateson chiama proto-apprendimento (apprendimento primario o apprendimento di primo grado) può essere contemplato a occhio nudo, monitorato e registrato, progettato e pianificato; il deutero-apprendimento invece è, per così dire, un processo sotterraneo quasi mai percepito consciamente e ancor meno di frequente monitorato dai suoi partecipanti, e solo vagamente collegato all’argomento apparente dell’istruzione. E’ nel corso del deutero-apprendimento, raramente sotto il controllo consapevole degli educatori incaricati o autoproclamatasi tali, che i destinatari dell’azione educativa acquisiscono competenze incomparabilmente più importanti per la loro vita futura rispetto alla minutaglia di conoscenze, anche la più scrupolosamente selezionata, che si combinano nei programmi di studio formali o informali. Essi acquisiscono ‘la capacità di cercare contesti e sequenze di un tipo piuttosto che di un altro, un’abitudine a segmentare il flusso degli eventi per evidenziarvi ripetizioni di un certo tipo di sequenza significativa…gli stati mentali che chiamiamo libero arbitrio, pensiero strumentale, passività, dominanza, etc. sono acquisiti tramite un processo che si può assimilare ad apprendere ad apprendere’… Molti anni dopo, come in una sorta di ripensamento, Bateson sentì il bisogno di completare il concetto di apprendimento di secondo grado, con quello di apprendimento di terzo grado o apprendimento terziario, quando il soggetto che partecipa al processo educativo acquisisce le competenze per modificare l’insieme delle alternative cha ha appreso ad attendersi ed a padroneggiare nel corso del deutero-apprendimento. Il deutero-apprendimento conserva il suo valore adattativo e compie appieno la sua funzione solo nella misura in cui i discenti hanno buone ragioni di attendersi che le contingenze che incontreranno andranno ad inserirsi in un determinato modello stabile; per dirla con parole diverse, l’utilità o l’iniquità delle abitudini acquisite nel corso del deutero-apprendimento dipende non tanto dalla diligenza e dai talenti dei discenti e dalla competenza e dalla solerzia dei loro insegnanti quanto dagli attributi del mondo in cui gli ex allievi sono destinati a vivere la loro vita… Tutti i punti di riferimento che davano solidità al mondo e favorivano la logica nelle strategie di vita (i posti di lavoro, le capacità, i legami personali, i modelli di convenienza e decoro, i concetti di salute e malattia, i valori che si pensava andassero coltivati e i modi collaudati per farlo), tutti questi e molti altri punti di riferimento un tempo stabili sembrano in piena trasformazione. Si ha la sensazione che vengano giocati molti giochi contemporaneamente e durante il gioco cambino le regole di ciascuno…con casualità e senza preavviso. In tali circostanze l’apprendimento terziario -l’apprendimento a violare la conformità alle regole, a liberarsi dalle abitudini, e a prevenire la loro formazione, a ricostruire le esperienze frammentarie in modelli precedentemente sconosciuti e nel contempo a considerare accettabili tutti i modelli solo ‘fino a nuovo avviso’- lungi dall’essere una distorsione del processo educativo e una deviazione dal suo vero obbiettivo, acquisisce un valore adattivo sommo e diventa rapidamente un elemento centrale dell’indispensabile ‘equipaggiamento della vita’. Agli esseri umani post-moderni è negato il lusso di presupporre, come il personaggio shakespeariano, che ci sia ‘del metodo in questa pazzia’. Se si aspettano una struttura coesa e coerente nella congerie di eventi contingenti, vanno incontro a costosi errori e dolore frustrazioni; se le abitudini acquisite nel corso dell’addestramento li spingono a cercare tali strutture coese e coerenti e a legare le proprie azioni alla loro identificazione sono veramente nei guai. Gli esseri umani postmoderni devono dunque essere capaci non tanto di portare alla luce una logica occulta nell’accumulo di eventi, o gli schemi che si celano in ammassi casuali di punti colorati, quanto di disfare da un momento all’altro i propri modelli mentali e strappare, con un solo rapido balzo della mente, le tele più elaborate; in breve, di maneggiare la propria esperienza allo stesso modo in cui un bambino gioca con il caleidoscopio che ha trovato sotto l’albero di Natale. Il successo nella vita (e dunque la razionalità) di uomini e donne postmoderni dipende dalla velocità con cui riescono a sbarazzarsi di vecchie abitudini piuttosto che da quella con cui ne acquisiscono di nuove. La cosa migliore è non preoccuparsi di costruire modelli; il tipo di abitudine acquisito con l’apprendimento terziario nel fare a meno delle abitudini… Quello che manca nella acuta analisi di Margaret Mead è una situazione in cui non è affatto chiaro chi funge da insegnante e chi da allievo, chi possiede la conoscenza da trasmettere e chi è collocato all’estremo ricevente della trasmissione, nè chi decide quale conoscenza deve essere trasmessa e degna di essere acquisita: in altre parole una situazione priva di struttura, o una diversa situazione con conseguente egualmente disorientanti, contrassegnata da un eccesso di strutture, parzialmente sovrapposte e incrociate, reciprocamente indipendenti e interrelate; una situazione in cui i processi educativi non sono affatto ben distinti dal resto degli impegni e dei rapporti personali e dunque nessuno è veramente ‘responsabile’… La mia ipotesi è che il senso opprimenti di crisi che, in misura maggiore o minore, è avvertito simultaneamente da filosofi, teorici, e professionisti dell’educazione, quella versione corrente della sensazione di ‘trovarsi a un crocevia’, la ricerca febbrile di una nuova definizione di sé e nello stesso tempo, idealmente, di una nuova identità, abbiano poco a che vedere con le sviste, gli errori o la negligenza dei pedagoghi professionisti o con le carenze della teoria educativa, ma molto a che vedere con la liquefazione universale delle identità, con la deregolamentazione e privatizzazione dei processi di formazione dell’identità, la dispersione dell’identità, la polifonia dei messaggi valoriali e la conseguente frammentarietà della vita che caratterizza il mondo in cui viviamo… La condizione postmoderna ha frammentato il grande gioco dei tempi moderni in tanti piccoli giochi scarsamente coordinati, ha devastato le regole di ciascuno e ha accorciato bruscamente la durata media di ogni sistema di regole. Al di là di tutto questo tagliare e ricucire, si ha la percezione dello sgretolamento del tempo, privo di quella continuità, cumulatività e direzionalità che sembrava possedere un centinaio di anni or sono; la vita frammentaria della postmodernità viene vissuta in una dimensione temporale episodica, e nel momento in cui gli eventi diventano episodi essi possno essere collocati in una narrazione storica coerente solo a posteriori; finchè viene vissuto, ciascun episodio può attingere esclusivamente da sé stesso tutto il significato e la finalità di cui abbisogna o che è in grado di raccogliere per continuare nel proprio svolgimento e giungere a compimento. Tutto sommato, il mondo in cui gli uomini e le donne dell’età postmoderna devono vivere e modellare le proprie strategie di vita premia l’apprendimento terziario, un tipo di apprendimento che le consolidate istituzioni educative, nate e maturate nella foga ordinatrice dell’età moderna, sono impreparate a maneggiare, e che la teoria pedagogica, sviluppata come riflessione delle ambizioni moderne e delle loro incarnazioni istituzionali può considerare solo con una miscela di stupore e orrore… Ma la storia non finisce qui. La rivoluzione tecnologica permanente trasforma in menomazioni le capacità acquisite e le abitudini apprese e accorcia bruscamente il ciclo di vita delle competenze utili, che spesso esauriscono la loro utilità e il loro ‘potere abilitante’ in un tempo inferiore a quello che è necessario per acquisirle e per certificarle… Inoltre i tipi di competenze richiesti per praticare occupazioni flessibili, nel complesso non comportano un apprendimento sistematico e a lungo termine; più frequentemente essi trasformano in svantaggio un corpo logicamente coerente e ben conformato di capacità di abitudini acquisite, che un tempo costituivano una risorsa… Il coordinamento (forse persino l’armonia preordinata) tra lo sforzo di ‘razionalizzare’ il mondo e lo sforzo di educare esseri razionali adatti ad abitarvi, ossia l’assunto di fondo del progetto educativo moderno, non pare più credibile. E con lo sbiadire della speranza di giungere a un controllo razionale sul habitat sociale della vita umana, il valore adattativo dell’apprendimento terziario diventa sempre più evidente. ‘Preparare per la vita’, compito perenne e invariabile di ogni educazione, deve significare per prima cosa coltivare la capacità di convivere giorno per giorno e pacificamente con l’incertezza e l’ambivalenza, con una pluralità di punti di vista, e con l’assenza di autorità infallibili e attendibili; deve significare inculcare la tolleranza della differenza e la volontà di rispettare il diritto ad essere differenti; deve significare il rafforzamento delle facoltà di critica e autocritica e del coraggio necessario per assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle relative conseguenze; deve significare l’addestramento alla capacità di ‘cambiare i contesti’ e di resistere alla tentazione di rifuggire la libertà, con l’ansia dell’indecisione che questa si porta dietro assieme alle gioie del nuovo e dell’inesplorato. Il punto è, però, che queste qualità possono difficilmente essere sviluppate pienamente attraverso quel processo educativo che meglio si presta ai poteri di progettazione e di controllo dei teorici e dei professionisti dell’educazione: l’aspetto che si esprime attraverso i contenuti verbali espliciti dei programmi di studio e si incentra su quello che Bateson ha chiamato proto-apprendimento. Si potrebbe nutrire maggiore speranza nella dimensione educativo del deutero-apprendimento che tuttavia sappiamo meno sensibile alla progettazione e a un controllo generale e totale. Invece le qualità in questione possono emergere soprattutto dalla dimensione dei processi educativi detta dell’apprendimento terziario, che è collegata non ad un programma determinato e alla definizione di un particolare evento educativo, ma proprio alla varietà di programmi ed eventi intersecantesi e concorrenti. Nei limiti in cui sono valide le osservazioni precedenti, la filosofia e la teoria pedagogica si trovano di fronte al compito inconsueto e impegnativo di teorizzare un processo formativo che non è guidato fin dall’inizio da un tipo di bersaglio pianificato in anticipo, di modellare senza conoscere o visualizzare il modello a cui mirare; un processo che nel caso migliore può fare presagire, mai imporre, i propri risultati e che ingloba tale limitazione nella propria struttura; in breve, un processo aperto, interessato più a rimanere aperto che a fornire un prodotto specifico, e timoroso più di una conclusione prematura che della prospettiva di una eterna inconcludenza. |
L'INTELLIGENZA DELLE ISTITUZIONI
Carlo Donolo, 1997 - Feltrinelli
L’INTELLIGENZA DELLE ISTITUZIONI: TRA POSSIBILITÀ E NECESSITÀ
Il volume di Carlo Donolo è stato pubblicato oltre vent’anni fa, eppure è di un’attualità straordinaria.
Per capirlo e ‘sentirlo’, basta leggere le parole accorate e appassionate (accorate perché appassionate) dell’introduzione, ed ascoltare la ‘radicalità’ della critica che esse esprimono nei confronti della politica, della dirigenza pubblica, della accademia, degli intellettuali, del mondo della informazione e della comunicazione.
Una radicalità così intransigente da risultare, almeno per la mia esperienza, in parte ingenerosa, come spesso accade quando si esprime un vissuto di delusione o addirittura di 'tradimento' (non a caso viene evocata la trahison des clercs), vissuto che a sua volta evoca una precedente speranza, illusione, amore (come nelle dinamiche intra-famigliari: si pensi alle illuminanti considerazioni contenute nel bellissimo testo di Mara Selvini Palazzoli sui 'Giochi psicotici della famiglia', non a caso anch'esso datato ma assolutamente attuale).
Ma con ciò che è accaduto in questi vent’anni, a me sembra che le parole di Donolo risuonino oggi ancora più forti e indichino, per chi abbia interesse ad ascoltarle, un percorso di analisi e riflessione (e anche di intervento) finalmente all'altezza delle questioni in campo, delle sfide del tempo, e della nostra intelligenza collettiva.
Come mi capita di osservare sempre più spesso, dovremmo valorizzare di più e meglio l'incredibile qualità delle tante buone pratiche di cui è disseminato questo lungo Paese, e deciderci una buona volta a trattarci (noi e coloro che verranno dopo di noi) con il rispetto e la considerazione che ci dobbiamo: per quello che facciamo, per come lo facciamo, per quello che abbiamo imparato facendolo, e che abbiamo solo il problema di riuscire ad esprimere, uscendo dalla gabbia dei dispositivi (a volte amministrativi, a volte socio-istituzionali, altre volte mentali) dai quali ci lasciamo troppo spesso incatenare.
Ma per fare questo, da un lato occorre 'pensare alto', e dall'altro occorre forse rimettere in discussione i meccanismi stessi della forma istituzionale che regola la nostra convivenza sociale (penso ai limiti dello stesso modello democratico, per come lo abbiamo fino ad ora conosciuto e praticato, nell'epoca dei social media e dell''oltremondo' suggestivamente evocato da Alessandro Baricco nel suo ultimo volume 'The Game').
Il quarto capitolo del testo di Donolo (‘La costruzione di standard come processo politico e istituzionale’) e l’ultima parte del suo volume (‘Apprendimento e capacità istituzionale’) sono stati per me fonte di stimolanti riflessioni, e di confronto non solo sul piano tecnico scientifico, ma anche su quello della pratica professionale, e cioè degli interventi di consulenza che progetto e realizzo da oltre trent'anni, spesso in organizzazioni pubbliche: interventi riflettendo sui quali ho elaborato, a mia volta, considerazioni e indicazioni operative (penso, per fare solo un esempio all'adozione di standard nella formazione, nell'orientamento, nei servizi per il lavoro).
Per chi come me è convinto, sulla base della propria esperienza di tanti anni, che la qualità della nostra vita abbia sempre più bisogno di istituzioni ‘intelligenti’, questo volume costituisce un compagno prezioso per attraversare l'estate: un compagno con il quale certo ho già dialogato in passato, ma con il quale, dopo tanto tempo, mi farà particolare piacere ripercorrere insieme gli stessi sentieri.
Sentieri che oggi ('così ricco di esperienza e di saggezza', come osserverebbe Konstantinos Kavafis in 'Itaca') vedrò con occhi diversi, e che esprimerò con parole nuove, fino a ridefinirli: e forse, proprio per questa via, fino ad identificare nuove soluzioni: in quel percorso di apprendimento che è uno dei compiti esistenziali che sento come più importanti.
Forse, il più importante.
Il volume di Carlo Donolo è stato pubblicato oltre vent’anni fa, eppure è di un’attualità straordinaria.
Per capirlo e ‘sentirlo’, basta leggere le parole accorate e appassionate (accorate perché appassionate) dell’introduzione, ed ascoltare la ‘radicalità’ della critica che esse esprimono nei confronti della politica, della dirigenza pubblica, della accademia, degli intellettuali, del mondo della informazione e della comunicazione.
Una radicalità così intransigente da risultare, almeno per la mia esperienza, in parte ingenerosa, come spesso accade quando si esprime un vissuto di delusione o addirittura di 'tradimento' (non a caso viene evocata la trahison des clercs), vissuto che a sua volta evoca una precedente speranza, illusione, amore (come nelle dinamiche intra-famigliari: si pensi alle illuminanti considerazioni contenute nel bellissimo testo di Mara Selvini Palazzoli sui 'Giochi psicotici della famiglia', non a caso anch'esso datato ma assolutamente attuale).
Ma con ciò che è accaduto in questi vent’anni, a me sembra che le parole di Donolo risuonino oggi ancora più forti e indichino, per chi abbia interesse ad ascoltarle, un percorso di analisi e riflessione (e anche di intervento) finalmente all'altezza delle questioni in campo, delle sfide del tempo, e della nostra intelligenza collettiva.
Come mi capita di osservare sempre più spesso, dovremmo valorizzare di più e meglio l'incredibile qualità delle tante buone pratiche di cui è disseminato questo lungo Paese, e deciderci una buona volta a trattarci (noi e coloro che verranno dopo di noi) con il rispetto e la considerazione che ci dobbiamo: per quello che facciamo, per come lo facciamo, per quello che abbiamo imparato facendolo, e che abbiamo solo il problema di riuscire ad esprimere, uscendo dalla gabbia dei dispositivi (a volte amministrativi, a volte socio-istituzionali, altre volte mentali) dai quali ci lasciamo troppo spesso incatenare.
Ma per fare questo, da un lato occorre 'pensare alto', e dall'altro occorre forse rimettere in discussione i meccanismi stessi della forma istituzionale che regola la nostra convivenza sociale (penso ai limiti dello stesso modello democratico, per come lo abbiamo fino ad ora conosciuto e praticato, nell'epoca dei social media e dell''oltremondo' suggestivamente evocato da Alessandro Baricco nel suo ultimo volume 'The Game').
Il quarto capitolo del testo di Donolo (‘La costruzione di standard come processo politico e istituzionale’) e l’ultima parte del suo volume (‘Apprendimento e capacità istituzionale’) sono stati per me fonte di stimolanti riflessioni, e di confronto non solo sul piano tecnico scientifico, ma anche su quello della pratica professionale, e cioè degli interventi di consulenza che progetto e realizzo da oltre trent'anni, spesso in organizzazioni pubbliche: interventi riflettendo sui quali ho elaborato, a mia volta, considerazioni e indicazioni operative (penso, per fare solo un esempio all'adozione di standard nella formazione, nell'orientamento, nei servizi per il lavoro).
Per chi come me è convinto, sulla base della propria esperienza di tanti anni, che la qualità della nostra vita abbia sempre più bisogno di istituzioni ‘intelligenti’, questo volume costituisce un compagno prezioso per attraversare l'estate: un compagno con il quale certo ho già dialogato in passato, ma con il quale, dopo tanto tempo, mi farà particolare piacere ripercorrere insieme gli stessi sentieri.
Sentieri che oggi ('così ricco di esperienza e di saggezza', come osserverebbe Konstantinos Kavafis in 'Itaca') vedrò con occhi diversi, e che esprimerò con parole nuove, fino a ridefinirli: e forse, proprio per questa via, fino ad identificare nuove soluzioni: in quel percorso di apprendimento che è uno dei compiti esistenziali che sento come più importanti.
Forse, il più importante.
|
Il brano che segue è tratto dall'Introduzione del volume: i grassetto sono invece a mia cura
Riscopriamo le istituzioni. Le riscopriamo quando ne abbiamo più bisogno e ci accorgiamo che quelle esistenti sono carenti o insoddisfacenti. O addirittura sono diventate fattore di crisi sociale, economica e morale. Allora tutti parlano di istituzioni, e in particolare gli attori politici, i protagonisti della vita pubblica attuali o potenziali. Il funzionamento delle istituzioni pubbliche interessa in primo luogo a loro, perché ne dipendono le loro chances di vita, la loro carriera e il loro successo. Mentre gli amministratori pubblici tendono a tenere basso il profilo, per non diventare troppo visibili ed esporsi così a indesiderati interventi riformatori, i politici di professione e le coorti dei loro aiutanti anche intellettuali tematizza la crisi istituzionale come causa di tutti i mali e come panacea dei mali che essi stessi hanno contribuito a produrre. Da anni, da troppo tempo, si discute di riforme istituzionali. Finora sono stati raggiunti due risultati: la delegittimazione del vecchio assetto normativo a partire dalla costituzione repubblicana, e la riforma, finora solo parziale e parzialmente riuscita, del sistema elettorale. All'orizzonte si profilano riforme dell'assetto centro/periferia in senso maggiormente federativo, la riforma fiscale, un intervento che ridisegna i ruoli rispettivi dei due presidenti e il loro modo di elezione e legittimazione popolare, la riforma della pubblica amministrazione. La mancata tempestiva adozione di misure di riforma istituzionale ben calibrate, specie nel corso degli anni '80, è stato un fattore determinante della crisi politica e morale culminata nel 1993-1994. Ma non si tratta solo di un fallimento della politica, della sua capacità riformatrice. Si tratta anche di cattiva e carente cultura istituzionale, anzi di un vero e proprio oblio di cosa sono e a cosa servono le istituzioni. Specie quelle pubbliche, destinate al governo degli affari collettivi e alla regia degli interessi e delle identità di lunga durata del paese. La cattiva cultura istituzionale, del resto un portato comune dell'evoluzione degli ultimi decenni su cui tanto insistono anche March e Olsen, ha certamente le sue radici nell'iperpoliticismo condiviso dagli attori politici pur nella diversità delle opzioni ideologiche e programmatiche. Ciò comporta il primato delle volontà politiche e cioè delle forze politiche. Anche quelle più socialmente radicate non sono in grado di sapere molto sulla società che sono chiamate a governare. Le culture storiche di organizzazione sono pallidi fantasmi e la loro sostituzione con versione più adeguate - la cosiddetta fantomatica cultura di governo, alla quale non sarebbe male aggiungere un po’ di senso dello Stato - resta un processo superficiale, come la cipria sulle parrucche settecentesche. Il ceto dei professionisti politici per necessità e destino è composto da incompetenti. Ma la loro ignoranza è più specifica e peculiare: sta nei loro meccanismi di difesa, variamente mascherati dietro appello all'autonomia della politica, alla responsabilità del ruolo, alla propria storia personale. Perciò si buttano sui sondaggi, perché così credono di sentire il polso della società. O discutono gli articoli di fondo con la stessa gravità con la quale gli impiegati lunedì mattina si dedicano giustamente al commento delle partite di calcio. L'ignoranza della politica è stata pervicacemente aiutata da una cultura accademica scolastica, ispirata a modellistiche apprese sui libri di testo, succube dei supposti modelli ideali di qualche altro paese - basti pensare alle ridicole dispute sulle varie scuole filofrancesi, filoinglesi o filotedesche in materia elettorale - con protagonisti pseudo esperti dell’ultima ora, cattivi consiglieri dei principi e cattivi imbonitori di audience televisiva. La cultura giuridica non ha fatto eccezione, perché - come già segnalava Von Hayeck – vittima anch'essa del positivismo e dell'economicismo imperanti. Ci sono giuristi che hanno fatto eccezione, ma non sono stati in grado di interferire con le preferenze mal fondate delle pattuglie aggressive dei riformatori “o la va o la spacca”. Nella babele linguistica che ha caratterizzato la discussione sulle istituzioni il gergo tecnico ha mascherato malamente le predilezioni per scorciatoie, semplificazioni e soluzioni ad personam, che destrutturavano il sistema istituzionale tra picconate e formule magiche, mentre si avviava una deriva - assai pericolosa per lo stesso regime democratico - plebiscitaria, populistica e di riduzione autoritaria della complessità della transizione cui la società italiana è chiamata. Se le idee contano quanto gli interessi, le cattive idee pesano anche più di questi. In tal senso si può dire ci sia stata nell'ultima crisi italiana una certa trahison des clercs, in quanto gli intellettuali, e soprattutto i giuristi e gli scienziati sociali, non hanno per niente mostrato una capacità di prendere parola e di attivare una voce ragionata, argomentata e responsabile. Ansia di protagonismo forse, ma anche paura del passaggio. Anche molta rassegnazione, in un mondo dominato dalla comunicazione fittizia massmediale a fronte dell’isolamento istituzionale e sociale dell'università e in generale dei saperi scientifici e professionali. Riscopriamo le istituzioni, almeno proviamoci. La crisi italiana è in primo luogo crisi delle basi morali della società, delle identificazioni e delle speranze collettive, crisi di credibilità delle istituzioni pubbliche, delusione rispetto alle capacità della politica di risolvere problemi. Le istituzioni pubbliche sono il patrimonio ereditato di problemi e soluzioni pregresse spesso obsoleti, anzi produttori di effetti perversi e di freno a tutte le possibili mete della società. Ma sono anche la sostanza di cose sperate per il futuro, modi per affrontare e risolvere problemi, ridurre rischi, aumentare capacità, perseguire valori dichiarati nelle prime righe della nostra Costituzione. Riscoprire le istituzioni significa cercare di capirle nel loro merito, nelle loro logiche specifiche, nella loro vita reale. Significa poi riconoscere le forme del mutamento, quelle volute e quelle non volute, quelle desiderabili e quelle perverse. Infine, implica la formulazione di un approccio a largo spettro nelle azioni miranti alla loro modificazione, nella considerazione che i fattori di mutamento in buona parte ci sono sconosciuti, che solo in parte le possiamo controllare, che non dobbiamo affidarci a panacee e a comode semplificazioni, sapendo che - come la povertà evangelica - le istituzioni saranno sempre con noi, nel bene nel male. Dobbiamo correggerle, anche profondamente, ma dobbiamo sapere che non tutto può dipendere da discussioni politiche, dibattiti legislativi, provvedimenti di legge, atti amministrativi, referendum o altro ancora. Le istituzioni cambiano soprattutto se cambia la relazione tra cittadini e istituzioni, e se le istituzioni sono in grado di indurre e aiutare questa riqualificazione dei loro rapporti. Cambiano se cambia la relazione tra addetti alle istituzioni e i loro compiti e la vita delle istituzioni. Cambiano se i saperi socialmente disponibili sono chiamati a dare una mano in modo meno occasionale e sporadico, e se nessun sapere presume un monopolio tale da spacciare la propria razionalità per sapere esclusivo e dominante. Riscopriamo le istituzioni se impariamo a guardarle con altri occhi, e se mettiamo al lavoro tutti i saperi che la società, nella sua divisione del lavoro, e nell'accumulo delle esperienze, ha raccolto per i tempi difficili. In democrazia le istituzioni siamo noi, un noi collettivo, nel quale purtroppo possiamo oggi identificarci solo a fatica e con ripugnanza: esse sono ormai diventate la nostra cattiva coscienza, sono la somma delle omissioni del passato, degli errori del presente, delle ipoteche sul futuro. |
10 TESI SULL'IMPRESA
|
|
Per scrivere, ci vuole un po’ di speranza.
Speranza che le idee maturate non siano importanti e interessanti solo per chi scrive, nonostante, o forse proprio a causa della loro differenza con il modo prevalente di pensare. O forse perché si sente talvolta dire che le idee mancano, almeno idee che implichino un ripensamento di fondo sull’organizzazione del nostro sistema economico. Il percorso di sviluppo delle idee qui esposte non è stato breve, e molte sono state pubblicate in linguaggio teorico e lavori scientifici. Ma solo ora mi sono risolta a scriverle con ‘leggerezza’ e ‘brevità’, in un formato adatto a un potenziale dibattito su questi temi al di fuori della comunità scientifica. Un motivo è che mi pare che uno spazio di dibattito sull’organizzazione economica si sia in effetti riaperto. Uno spazio di ripensamento nato dalla crisi? Probabilmente. Quali ne siano le ragioni, un’occasione da non perdere per discutere e forse – la speranza che non si osa quasi esprimere – per cambiare. Perché di cambiamento delle concezioni e nelle pratiche più diffuse, e considerate ‘normali’, nell’organizzazione economica ci sarebbe disperato bisogno. In effetti, nella discussione sulle cause e i rimedi della presente crisi economica, non si fa che parlare di riforme; e il modo in cui se ne parla è un’ulteriore motivazione a scrivere. In primis, per ciò che manca nelle discussioni sulle riforme. Il dibattito si è in larga parte concentrato su temi macroeconomici: più o meno tasse, più o meno libero mercato e flessibilità, più o meno regolazione dei mercati finanziari… Ma nessun mercato, nessun gioco funziona se i giocatori sono impazziti. Come avere buoni giocatori? Oscar Wilde ebbe a dire che non esiste un marito ideale, se è l’istituzione del matrimonio a essere sbagliata. Parimenti, non esistono giocatori buoni se le istituzioni che li costituiscono sono sbagliate. E tra i giocatori più importanti vi sono, senz’altro, le imprese. Questo libro sostiene che la crisi che viviamo sia una crisi dell’istituzione impresa, tanto quanto se non più di quanto non sia una crisi del mercato. […] Il risultato di queste elaborazioni sulla natura,l'organizzazione e il governo dell'impresa, sono qui presentate in 10 tesi: un formato che si spera adatto a stimolare un dibattito ampio su troppe verità (o falsità) date per scontate; con il supporto di dati e casi soprattutto sulla realtà italiana. Le tesi sono perciò presentate in contrasto con altrettanti 'luoghi comuni' che esse contraddicono e si candidano a sostituire. Infatti, una parte troppo vasta dei dibattiti che si svolgono attorno alle famose riforme di cui tutti parlano, sono zeppi di quei luoghi comuni, da cui non può venir fuori nulla di buono e certamente nulla di nuovo; per giunta sorprendentemente diffusi tra i diversi soggetti e parti che hanno il potere e la responsabilità di agire – rappresentanti del governo, dei partiti, delle imprese, dei sindacati. Dunque il proposito principale di questo scritto è proporre una riforma dei concetti e del linguaggio, come base e premessa per qualsiasi riforma saggia del sistema economico e organizzativo reale. Credo che questo sia un contributo che almeno qualcuno tra chi ha il privilegio di dedicarsi per mestiere alla conoscenza e allo studio abbia il dovere di dare, cercando di seguire l’accorto invito di Max Weber a cercar di pensare sé stessi e il proprio ruolo come ‘intellettuali’ piuttosto che come ‘autori’, ‘consiglieri’ o ‘tecnici’. [...] Perciò l’ultima nozione comune che sarebbe probabilmente bene abbandonare, forse la madre o forse la figlia di tutti i luoghi comuni, è quella di ‘capitalismo’. Essa è ampiamente ancora utilizzata sia dai suoi sostenitori sia dai suoi critici è [per es. Baumol et al. 2013; Rifkin 2014; Pikketty 2014]. Tuttavia, continuare a pensare e a dire che siamo in un ‘sistema capitalistico’, rischia di dare continuità a idee obsolete sulla natura dell’impresa e del nostro sistema economico, ostacolandone una piena evoluzione come società democratica fondata sul diritto, che già in buona parte esiste. Non solo per la concezione d’altri tempi dell’impresa che il termine capitalismo contiene. In aggiunta, perché esso perpetua pure l’idea, presente nelle concezioni sui possibili sistemi economici che prevalsero nel secondo ‘800, che il ‘sistema capitalistico’ sia composta dal ‘modo capitalistico di organizzazione della produzione’ e dal ‘mercato come organizzazione degli scambi’, come se componessero un ‘sistema’ inscindibile, cui ne andrebbero contrapposti altri. In realtà, il mercato è un innovazione molto più antica dell’era capitalistica. Può funzionare benissimo con unità produttive di natura molto varia, non solo imprese di diversa forma e diversa struttura proprietaria, ma anche tra unità che imprese non sono affatto. E anche nel caso dei mercati finanziari, se le prime forme di societas si fanno risalire ai romani, le prime forme di Borsa, vengono fatte risalire ai Greci. ‘Borse valori’ e mercati finanziari di vario genere si formarono e funzionarono prima e senza imprese ‘capitalistiche’; e, nel presente, i mercati finanziari funzionano anche con imprese ‘non capitalistiche’ (per esempio cooperative che emettono azioni). Questa varietà di combinazioni possibili era stata vista ai tempi in cui il dibattito sulla natura dei sistemi economici ebbe origine – per esempio la combinazione tra mercato e unità produttive democraticamente governate era presente in elaborazioni che poi non ebbero seguito di massa, come quelle di alcuni cosiddetti ‘socialisti utopisti’. Poi, come è successo con la varietà dei vangeli all’origine della chiesa cristiana, una visione ha prevalso e le altre sono state dimenticate. Ma quando, se non in tempi di crisi della verità in voga, varrebbe la pena di riscoprire le incertezze e i dubbi che avevano pur accompagnato il sorgere? Molto del futuro si può trovare nel presente, basta saper guardare, è stato detto; e, a saper ben guardare, un po’ di futuro si può trovare anche nel passato remoto. (tratto dalla premessa e dalle conclusioni del volume)
|
IL MALINTESO
|
|
Il malinteso è molto poco egualitario: la sua stessa definizione è un partito preso.
Ciò implica che ci sia una giusta versione: ‘un beninteso’. Quando dico che c’è stato un malinteso, intendo dire che ‘rispetto ad una giusta interpretazione’ qualcuno ha deviato per mancanza d’attenzione, poca volontà, ostruzionismo o stupidità. Ma è pur vero che nella pratica sappiamo tutti che è facile essere vittime o artefici di un malinteso. Non per questo smettiamo di parlarci l’un l’altro. Perché il malinteso è una trappola dell’incontro, un qualcosa che può accadere, senza che poi io e tu lo vogliamo. Il malinteso, nella splendida accezione del filosofo francese Wladimir Jankelevitch, è un ‘quasi niente’. Se fosse di più non saremmo caduti nella sua trappola. Ma il ‘quasi niente’ è talmente importante da farci capire che c’è qualcosa del mio pensiero che non è stato possibile dirti. Questa ‘sfumatura’ ha a che fare con i nodi intimi dell’identità (è il ‘non so che’ compagno del ‘quasi niente’ per Jankelevitch) e non è traducibile. Se si cerca di eliminare questo ‘quasi niente’ si riduce il dire a un detto e chi dice ad un suo enunciato. Nei rapporti tra culture diverse avviene qualcosa di analogo. Dovrebbe esserci implicita la consapevolezza di una differenza intraducibile da una cultura all’altra, così come c’è sempre qualcosa di intraducibile da una lingua all’altra. Le culture sono incommensurabili. Le si può mettere accanto, ma non coincidono, né ‘combaciano’. Da qui l’inestinguibilità dei malintesi. Eppure le culture – è l’esperienza storica che ce lo racconta – si sono spesso incontrate, hanno convissuto, si sono incrociate. I luoghi ed i momenti dell’incontro sono stati altrettanto frequenti quanto quelli dello scontro. Come hanno fatto? Perché non hanno cercato disperatamente di tenersi separate? Perché non sono rimaste fedeli ad una idea di identità a cui sta a cuore il non essere fraintesa, ridotta deformata? Perché allo scetticismo della contestazione – i malintesi sono inevitabili – non è corrisposta sempre e dovunque una pratica della ‘evitazione dell’incontro’? La risposta può essere che i malintesi a volte diventano lo spazio in cui le culture si spiegano e si confrontano, scoprendosi diverse. Il malinteso è il confine che prende una forma. Diventa una zona neutra, un terrain-vague, dove l’identità, le identità reciproche si possono attestare, restando separate appunto da un malinteso. Il malinteso può, in questo senso, difendere l’identità interna di una persona o di una cultura. Ma i malintesi offrono anche uno spazio di spiegazione. Il malinteso è allora una occasione di traduzione, una zona di cui l’incommensurabilità tra persone o tra culture arriva a patti. Questo testo vuol provare a chiarire a cosa servano i malintesi, vuole descrivere cosa il malinteso ‘ci fa’ e cosa con esso ‘si può fare’. Cercheremo di distinguere il malinteso di cui siamo vittime e quello di cui siamo attori o addirittura promotori. Questo caso, come il caso più generale della gestione del malinteso, ha a che fare, vedremo, con delle ‘pratiche’ con una competenza dei rapporti, con un ‘sapere’ culturale rispetto agli altri e alla alterità, con un’arte di vivere e di convivere nonostante o proprio grazie al malinteso. Il malinteso, insomma, vuole essere indagato qui come forma di strategia interpersonale e interculturale che prepari, produca e consenta la tolleranza. Sapendo che esso è per sua natura equivoco e difficile da imbrigliare, questa non sarà un’opera facile e ci darà da penare. Non si dovrebbe mai dimenticare che il malinteso ‘ci fa soffrire’, è una situazione disagevole e poco simpatica: ci fa sentire la ruvida sensazione dell’attrito che esiste tra le pieghe della nostra alterità. (tratto dalla 'Introduzione' del volume)
|
L'UMILTÁ DEL MALE
Franco Cassano, 2011 - Editori Laterza
|
Il pessimismo del Grande Inquisitore è in realtà una guerra antropologica preventiva ed efficacissima contro la speranza.
La sua forza rispetto ai dodicimila eletti sta tutta qui, nella consapevolezza della fragilità dell'uomo. Gli eletti, ispirandosi a modelli alti ed esigenti, si propongono di combattere contro la fragilità dell'uomo, contro i suoi difetti, spesso forzandone la natura. Il Grande Inquisitore lavora proprio su questa soglia, a dividere gli uomini migliori da tutti gli altri, a presentarli come un'aristocrazia boriosa e innamorata della propria perfezione. Lo scarto su cui egli lavora è uno scarto reale, ma egli lo esaspera, lo accentua e lo allarga, lo porta ben oltre il punto in cui lo aveva trovato, coltiva e alimenta la debolezza dell'uomo, perché ne ha bisogno, perché essa è il fondamento della sua forza. Egli dunque lavora, e duramente, non solo contro il messaggio di Cristo, ma contro tutti coloro che, anche sulla sua scorta, provano a spingere l'umanità verso mete spirituali elevate, ha bisogno di credere che esse portino in realtà soltanto verso un abisso. È quindi una lotta durissima quella contro il Grande Inquisitore: egli si è alleato con la debolezza degli uomini, la moltiplica e la usa come uno scudo contro i migliori tra essi. Per pensare di poterlo combattere con qualche successo occorre evitare di separare i dodicimila santi da tutti gli altri uomini, occorre non solo combattere, ma anche riconoscere e rispettare l'angustia dell'uomo, occorre tenere i collegamenti, evitare che le file si allontanino troppo l'una dall'altra, è necessaria un'idea di perfezione e salvezza diversa, libera da ogni angelismo e capace di ospitare al suo interno quella debole e imperfetta creatura che è l'uomo. (tratto dal primo capitolo del volume)
|
SCARCITY
PERCHÉ AVERE POCO SIGNIFICA TANTO
Sendhil Mullainathan - Eldar Shafir, 2014 - Il Saggiatore
Questo volume contiene anche un capitolo dedicato al tema della competenza (uno dei temi principali della mia riflessione), e allo sviluppo della teoria della ‘larghezza di banda’ (proposta dagli autori) in relazione ad esso.
Ma come sempre succede, ‘frequentandolo’ ho scoperto che il volume contiene molte più cose di quelle che mi ero inizialmente prefigurato.
Ma come sempre succede, ‘frequentandolo’ ho scoperto che il volume contiene molte più cose di quelle che mi ero inizialmente prefigurato.
|
Per scarsità intendiamo ‘avere meno di quanto pensiamo ci occorra’…
Scoprire una logica comune nella scarsità avrebbe importanti implicazioni. ‘Scarsità’ è un concetto ampio: il problema della disoccupazione, per esempio, è anche un problema di scarsità di mezzi finanziari. La perdita del lavoro irrigidisce subito il bilancio familiare: il reddito è troppo poco per coprire il mutuo, le rate dell’auto e le spese correnti giorno dopo giorno. Il problema del crescente isolamento sociale (‘giocare a bowling da soli’) è una forma di scarsità: si tratta di persone che hanno troppo pochi legami sociali. Il problema dell’obesità, per quanto possa sembrare controintuitivo, è anche un problema di scarsità. Seguire una dieta richiede che si affronti la sfida di mangiare meno di quanto si è abituati: un budget calorico ristretto, ossia scarsità di calorie. Il problema della povertà globale, la tragedia di moltitudine di persone che vivono con 12 dollari al giorno, è un altro tipo di scarsità, finanziaria. A differenza della repentina, ma spesso transitoria, contrazione di un bilancio familiare (causato dalla perdita del lavoro), povertà vuol dire ristrettezza di budget perpetua… La scarsità non è solo un limite fisico. È anche uno stato mentale. Quando cattura la nostra attenzione, la scarsità cambia il nostro modo di pensare - a livello di millisecondi, come di ore, giorni o settimane. Insediandosi al centro dei nostri pensieri, influenza ciò che osserviamo, il modo in cui valutiamo le opzioni e, in ultima analisi, che cosa decidiamo e come ci comportiamo. Quando ‘funzioniamo’ in condizioni di scarsità, i problemi ci appaiono diversi e li affrontiamo in maniera diversa… Quando la scarsità cattura la mente, diventiamo più attenti ed efficienti. Tuttavia non siamo liberi di scegliere quando la nostra mente sarà catturata. Pensiamo ad un progetto incombente non solo quando siamo al lavoro, ma anche quando siamo a casa e stiamo cercando di aiutare nostra figlia a fare i compiti. La stessa cattura automatica che ci aiuta a concentrarci ci diventa un fardello negli altri aspetti della vita. Siccome siamo preoccupati per la scarsità, poiché la nostra mente vi torna costantemente, abbiamo meno attenzione da prestare a tutto il resto. Questa è più di una metafora. Possiamo misurare direttamente la capacità mentale, ossia, come diciamo noi, la larghezza di banda. Possiamo misurare l’intelligenza fluida, una risorsa che influenza il modo in cui elaboriamo le informazioni e prendiamo le decisioni. Possiamo misurare il controllo esecutivo, una risorsa essenziale che incide sull’impulsività del nostro comportamento. E scopriamo che la scarsità riduce tutte queste componenti della larghezza di banda: ci rende meno intuitivi, meno lungimiranti, meno controllati. E gli effetti sono consistenti. Essere povero, per esempio, riduce la capacità cognitiva di una persona più di un’intera notte senza dormire. Non è che i poveri abbiano una minore larghezza di banda come individui. È l’esperienza della povertà che riduce la larghezza di banda, per chiunque… In un certo senso, la tesi di questo libro è piuttosto semplice. La scarsità cattura la nostra attenzione, e ciò ci fornisce un limitato vantaggio: lavoriamo meglio quando dobbiamo gestire esigenze pressanti. Ma, in termini più generali, ci costa caro: trascuriamo altri interessi e diventiamo meno efficaci in tutto il resto della nostra vita. Questa tesi non contribuisce solo a spiegare come la scarsità modelli il nostro comportamento; produce anche risultati sorprendenti e getta una nuova luce sul modo in cui potremmo gestire la nostra scarsità. (tratto dall’Introduzione al volume, da parte degli autori)
|
x
Conoscersi per comprendersi, riconoscersi, integrarsi.
LINK
Albert-László Barabási, 2004 - Einaudi Editore
Un testo particolarmente interessante e a tratti illuminante (almeno per me, che non sono un esperto di questo specifico ambito). A posteriori, un autentico insight sulla dinamica delle diffusioni ‘virali’, oggi così drammaticamente di attualità.
|
All'inizio del ventunesimo secolo, un gruppo di scienziati sostiene che tutte le reti hanno in comune un ordine e che si comportano secondo alcune regole. Lo scienziato che per primo è riuscito a "mappare" la struttura complessiva del World Wide Web, racconta la storia dei sistemi connessi, cominciata nel Settecento con Eulero e giunta oggi a sviluppare nuove cure contro il cancro. L'autore illustra il lavoro di mappatura delle reti in un vasto ambito di discipline, nella convinzione che la rete sociale, le compagnie d'affari e le cellule sono molto più simili di quanto si pensi. Descrive le applicazioni concrete della nuova scienza, spiega come "Google" sia diventato il motore di ricerca più popolare e come la rete abbia condizionato l'economia americana. |
Riproduzione per finalità culturale o didattica, dispositivo dell’art. 70. Legge sulla protezione del diritto d’autore