|
Maura Franchi, Augusto Schianchi, 2021, Diabasis 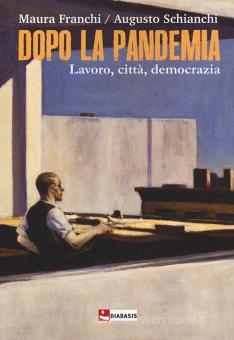 Conosco Maura Franchi da molto tempo. In un ormai lontano passato ho apprezzato le sue qualità di ricercatrice in ambito economico-sociale. Successivamente ho avuto modo di conoscerla personalmente nel periodo in cui ha ricoperto ruoli di direzione nella Regione Emilia-Romagna, nell’area delle politiche e dei servizi per il lavoro. In quel periodo abbiamo realizzato insieme (lei come dirigente dell’Amministrazione, io come consulente) attività di ricerca-intervento e di formazione dei dirigenti e dei quadri delle Amministrazioni provinciali impegnati in tale ambito. Attività che considero ancora oggi esemplari sia dal punto di vista strategico, sia da quello tecnico-metodologico. A qualche anno dalla conclusione di questa esperienza, dopo che si è dedicata alla ricerca e all’insegnamento nell’Università di Parma, abbiamo insieme curato il volume ‘Biografie in transizione. I progetti lavorativi nell’epoca della flessibilità’, frutto di una riflessione collettiva realizzata grazie alla sua instancabile capacità di iniziativa, e di vera e propria ‘intraprendenza culturale’ in ambiti apparentemente anche molto diversi tra loro (politica, sociologia dei consumi, politiche del lavoro, etc.). Con Augusto Schianchi, Maura Franchi ha condiviso la pubblicazione di diversi volumi, in un percorso di riflessione comune di cui ‘Dopo la pandemia. Lavoro, città, democrazia’ costituisce l’approdo più recente. Ho trovato particolare sintonia e interesse per i contenuti di questo testo, ed anche per il ‘tono’ utilizzato per trattarli: lontano da quel manicheismo ‘urlato’ (finto dispensatore di impossibili certezze) che sembra ormai la cifra corrente. Mi fa piacere riproporre di seguito le considerazioni finali degli autori, che nel testo sono precedute da tre capitoli:
P.S. La citazione che apre l’introduzione (‘E’ da arroganti pensare di controllare tutto. Per questo Dio manda i tornado, per ricordarcelo’), tratta dalla serie Atlantic ‘Fargo’, con la sua elementare e ‘pedagogica’ ironia costituisce il viatico più appropriato per la lettura: premessa e promessa (onorata) di un testo particolarmente stimolante Cosa abbiamo imparato[1] Things will get worse before they get better (Dr. Anthony Fauci) Il nostro saggio cerca di mettere a fuoco tre ambiti su cui la pandemia ha già manifestato forti conseguenze e continuerà ad averne in futuro: il lavoro, le città, la democrazia. Che cosa abbiamo imparato da questa storia, peraltro in corso? Abbiamo imparato che esiste una vita parallela alla nostra, quella del virus - in realtà non una vita, in quanto non metabolizza alla luce del sole – che sta mettendo a rischio un’altra vita, la nostra. La storia è piena di episodi in cui virus piccolissimi ci hanno aggredito e sterminato. Li avevamo rubricati come fatti del passato. Ma ora si sono riproposti altri inaspettati episodi che abbiamo cercato di affrontare con l’ottimismo che la scienza ci consente. Abbiamo compreso che il Covid non era una semplice influenza come volevamo sperare. Il bisogno di solidarietà si è infranto contro la crescita delle diseguaglianze, le differenze sociali e culturali e la frammentazione degli interessi. Abbiamo incontrato una politica talvolta salottiera, spesso impotente, ospite di gala dei numerosi talk show. Il governo ha imposto il lockdown che nei tempi passati si sarebbe chiamato coprifuoco. Da veri italiani che danno il meglio quando sono messi peggio, ci siamo adattati. Il telelavoro, termine che aveva sostituito il vecchio lavoro a domicilio, si è trasformato in smart working, in cui si coniugano capacità di adattamento, intelligenza e l’antica tradizione artigianale delle botteghe rinascimentali. Siamo diventati imprenditori di noi stessi. Lo smart working ci spingerà a desiderare abitazioni che comprendano nuovi spazi. Intanto abbiamo cercato di attrezzare gli spazi domestici affinché potessero contenere tutto: lavoro, ricreazione, gioco, conforto. La casa si è trasformata in trincea, come quelle sui nostri monti al tempo della grande guerra, quelle trincee contenevano tutto, compresa la fiducia necessaria per sopravvivere e per vivere. Così abbiamo pensato a come avrebbero potuto essere le nostre città, lavorando a casa. Abbiamo anticipato i progetti dei nostri grandi architetti, abbiamo riletto il maestro Calvino e le sue città invisibili. Venezia è diventata il simbolo della nuova città, un arcipelago dislocato su tante isole, una rete di piccoli territori interconnessi separati e uniti al tempo stesso, separati dal mare che unisce senza sommare, separa senza allontanare. Le costrizioni del confinamento hanno portato ognuno di noi a interrogarsi su questioni inedite. Abbiamo vissuto in uno spazio chiuso e in una strisciante condizione di paura. Ci siamo illusi talvolta che la pandemia fosse alle spalle, e poco dopo abbiamo sperimentato l’inconsistenza felle nostre speranze. Il Coronavirus ha fatto irrompere la morte come possibilità per ognuno e un nuovo senso di impotenza rispetto al pericolo che avevamo difronte. Il confinamento ci ha reclusi all’interno delle nostre case, con la ricorrente illusione che fossimo ogni volta difronte all’ultimo sacrificio. Il confinamento è stato una lente di ingrandimento delle diseguaglianze sociali: le abitazioni più anguste e affollate hanno reso il confinamento invivibile, ma le persone sole hanno vissuto una solitudine altrettanto dura. Abbiamo visto diseguaglianze che avevamo rimosso, quelle della donna, in primo luogo, più impegnate in lavori di cura, nel fronteggiare nuove esigenze, quelle dei figli, dei nipoti, dei genitori anziani. La pandemia ha colpito il mondo in modi diseguali e ha diffuso uno stato di ansia. Ci siamo interrogati, talvolta senza avere neppure consapevolezza, sulla nostra civiltà. Ci siamo ritrovati senza risposte. Una crisi dell’intelligenza, così Morin ha definito il buco nero che si è manifestato davanti a noi di fronte alla pandemia. L’incertezza dei rimedi ci ha messo di fronte all’inadeguatezza delle nostre conoscenze. Abbiamo capito che avevamo rimosso il rischio non solo dalla vota quotidiana, ma anche dalle categorie mentali con cui pensavamo la nostra esistenza. In questi mesi esigenze di protezioni sanitarie si sono scontrate con la necessità di favorire la ripresa economica, la necessità di salvaguardare la nostra libertà individuale con misure di tracciamento individuale. La crisi sanitaria è ancora in corso e insieme a questa vediamo l’esplosione del numero dei disoccupati e dei lavoratori precari. Crisi sociale, crisi economica e crisi politica sono con evidenza davanti a noi. Una crisi esistenziale quella che stiamo vivendo, che ci impone un nuovo rapporto con il tempo, che conosce una obbligata decelerazione, consentendoci di sperimentare talvolta il gusto della lentezza e della riflessione. Nello spazio chiuso sono emerse talvolta nuove abitudini sociali, gli scambi di aiuto con i vicini hanno dato luogo a nuove amicizie. Abbiamo sperimentato modi dimenticati per trascorrere il tempo: leggere, vedere film, ascoltare musica. Qualcosa di queste abitudini resterà per favorire modi di vivere più attenti al valore della reciprocità. Sul fronte della politica, per citare ancora Morin ‘è emerso chiaramente che la globalizzazione, poiché essenzialmente tecno-economica, ha creato una generale interdipendenza priva di ogni solidarietà’. Il Covid è stata l’occasione per ripensare il nostro modo di stare insieme, di essere uniti e separati al tempo stesso. Ci siamo chiesti come il nostro stare insieme potesse prescindere dall’idea del mondo di ciascuno. Come nella metafora dei porcospini, proposta da Arthur Schopenhauer, abbiamo cercato la distanza ‘giusta’ per scaldarci senza pungerci. Abbiamo capito la necessità delle decisioni in tempi rapidi, abbiamo scoperto l’importanza delle competenze, abbiamo ascoltati i virologi con l’attenzione delle antiche tribù verso gli sciamani. Abbiamo capito ancora una volta che rappresentare il popolo non basta; bisogna mettersi al servizio della comunità, perché nei momenti di grande difficoltà, è necessario il contributo di tutti secondo le capacità di ognuno. Abbiamo scoperto la resilienza, quell’atteggiamento soggettivo che scaturisce da prove difficili, che si percepisce quando si supera un’avversità e si può guardare indietro e ragionare su quanto si è stati forti in quella circostanza e sulla saggezza che abbiamo elaborato. Ora siamo in condizioni di guardarci indietro. Quasi non riusciamo a spiegare come siamo riusciti a fronteggiare questo tempo che peraltro non è ancora alle spalle. [1] Tratto da: Maura Franchi, Augusto Schianchi ‘Dopo la pandemia. Lavoro, città, democrazia’ Diabasis 2021 评论已被关闭。
|
PIER GIOVANNI BRESCIANIPsicologo, Fondatore di Studio Méta & associati, Professore a contratto presso Università di Urbino |



